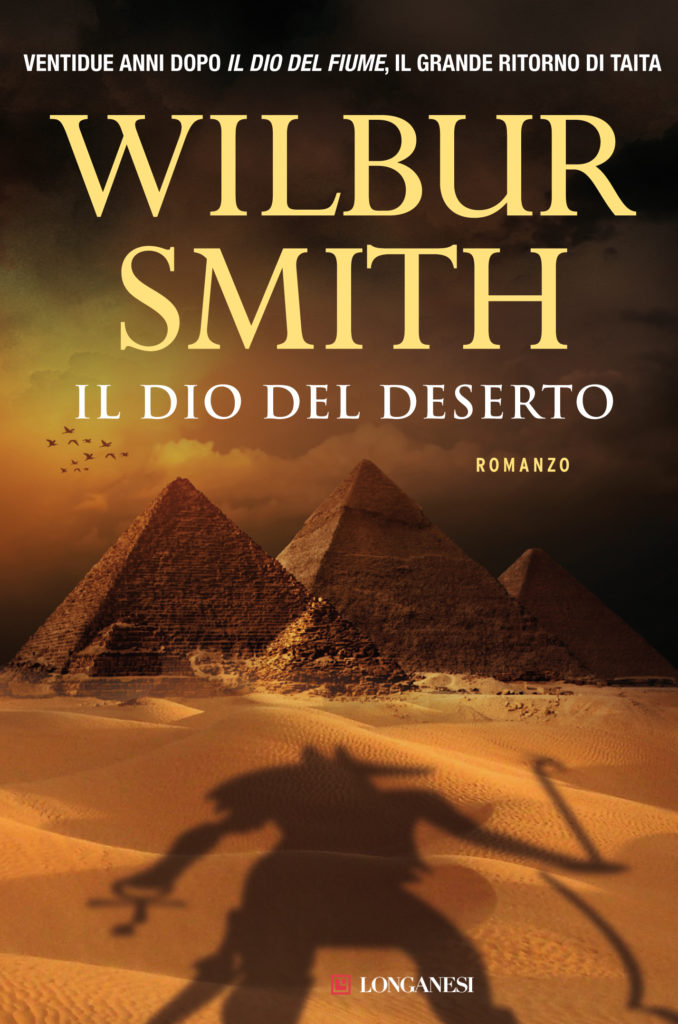
Il dio del deserto (Il)
Articolo di Carlo Amedeo Coletta
Ho letto: Il Dio del deserto
Autore: Wilbur Smith
Da dove iniziare? Conoscete l’autore? E chi non lo conosce! Diamine, Wilbur Smith, un maestro della letteratura contemporanea, a quanto dicono, a quanto pare. Uno che, comunque, di professione è davvero uno scrittore. Uno che non solo ci campa ma che è diventato famoso. Deve essere per forza bravo uno del genere, dai! Wilbur Smith! E mica un Carlo Amedeo Coletta qualunque, ci mancherebbe.
Evidentemente ho iniziato a conoscerlo partendo dal libro sbagliato. Non c’è altra spiegazione. Eppure ne ha scritti tanti. Eppure in libreria ce n’erano ancor di più, anche di altri autori. Ho scelto questo però: Il Dio del deserto. Perché? Me lo sono chiesto dalla quarta pagina fino alle quattrocentonovantunesima. Sì, scritto in lettere e non in numero, 491esima, fa ancora più impressione. Sono arrivato a due conclusioni: la prima è che volevo effettivamente conoscere questo celebre autore. La seconda è che la copertina del libro è gialla. Non giallo deserto, però. Un giallo acceso, vivo. Sono della Vergine, è il mio colore preferito. Come potevo restare indifferente?
Bene, sono certo che Wilbur Smith è un grande autore. Mi fido di ciò che ho sentito dire in giro, non sto neanche a verificare. E’ così e basta. E’ chiaro che anche un autore del genere può scrivere qualcosa di leggermente meno eccelso del solito. E può essere che proprio io sia incappato in quest’opera. Succede. Non vi scandalizzate. Ora vi spiego anche i motivi di questa mia profonda perplessità. Non sto mica a buttare parole al vento. Con quello che costano, non si butta via nulla qui.
Siamo nel deserto dell’antico Egitto. Un ex schiavo, affrancato dal suo padrone e divenuto eroe d’Egitto per antiche e mirabolanti imprese non meglio precisate (sarebbe necessario leggere i libri precedenti ma, anche in questo caso, mi fido. Sono certo fosse un mito vivente ma volevo dire un figo allucinante in verità!), viene incaricato dal nuovo Faraone di curare gli interessi della nazione, mettendo alla forca la popolazione degli Hyksos per dare all’Egitto l’accesso al mar mediterraneo. Gli Hyksos sono brutta gente, guardate. Di quelli che non ci penserebbero due volte a darvi quattro ceffoni in mezzo alla strada ma Taita, questo il nome del protagonista, è uno che conosce bene l’arte militare. Non gli sarà difficile soggiogare e vincere la resistenza di questo popolo. Taita, non più giovane ma dotato di caratteristiche quasi divine, ha la forza di una mandria di buoi, l’intelligenza di tutti i premi Nobel messi insieme, l’intuito di un feroce predatore, la saggezza di Osho e la sapienza dell’intera biblioteca alessandrina. E il romanzo è anche scritto in prima persona, quindi Taita se le canta e se le suona da solo. E’ un bullo convinto di essere il meglio del meglio del meglio. E tutti gli vanno dietro. Ce ne fosse uno in 491 pagine che osi mettere in dubbio le sue parole. In mezzo a tutte queste qualità di tutto rispetto, osannato da chiunque ma soprattutto da se stesso, passa quasi in secondo piano che sia stato evirato sin da piccolo. Uno scherzetto, forse, di quando si sentiva il miglior schiavo d’Egitto. Peccato. Si sarebbe potuto riprodurre e mettere al mondo tanti piccoli e insopportabili Taita. Ma andiamo avanti.
Sconfitti gli Hyksos, il faraone affida a Taita una nuova missione. In fondo, per arrivare a 491 pagine qualcosa doveva pure trovargli da fare. C’è da stringere un’alleanza con i babilonesi, a quanto pare molto indebitati al punto che Taita sente odore di povertà e se ne va presto, e con i cretesi, sudditi di re Minosse, ricco e potente. Ovviamente Taita è stato scelto dal faraone per le sue impressionanti qualità di negoziatore, è evidente. Re Minosse, però, almeno all’inizio, dimostra di essere cretese e non cretino come Taita vorrebbe far pensare. Il caro Re di Creta, infatti, per stringere l’alleanza chiede che gli siano portate in moglie le figlie della donna che Taita ha sempre amato ma che non ha mai potuto toccare per via di certi impedimenti di cui vi ho raccontato sopra. E Taita, fedele scudiero dell’Egitto, pur amando quelle fanciulle come fossero sue figlie, accetta. Tornerà a casa, caricherà su una nave meravigliosa le fanciulle e le porterà a Creta. Il viaggio sarà piuttosto breve nonostante la notevole distanza e tutto grazie alle indiscutibili e impressionanti qualità di Taita nell’arte del navigare. Era chiaro. Lo dice lui stesso, di se stesso, a se stesso. E qui, una volta arrivati a Creta, senza svelarvi il finale, sappiate solo che se l’arroganza di Taita non vi è bastata per buttare il libro dalla finestra, la mano artistica di Wilbur Smith vi aiuterà nella realizzazione di tale intento.
E’ stato veramente uno sforzo importante arrivare all’ultima pagina. Di solito, finendo un libro, mi rimane sempre un po’ di amaro in bocca. Mi dispiace dover abbandonare questo o quel personaggio. Mi dispiace aver saputo la verità su eventi, sentimenti, delitti e misfatti. Questa volta, invece, dopo aver letto l’ultima riga, ho mandato Wilbur Smith e Taita proprio in Egitto. E ho pensato: ma questo tizio qui, vecchio ma giovanissimo, bello, intelligente, maestro nell’arte della guerra, della navigazione, della strategia, della negoziazione, della medicina, della magia, della finanza, proprio questo Taita qui insomma…ma pensa se non era evirato che macelli che faceva in giro! Tutti grandissimi figli di Taita saremmo stati. E’ andata bene così. A volte poter richiudere un Taita in un libro e riporlo sotto il tavolo che balla è un pensiero rasserenante.
Buona lettu…dormite, è meglio. Buona notte!
